text_yesterdaynow - barbara nahmad
Menu principale:
text_yesterdaynow
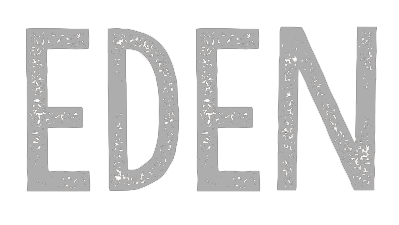
HAADAM HAHADASH
di Martina Corgnati
Da lungo tempo Barbara Nahmad ha fondato la sua ricerca su immagini già esistenti, riproposte in serie coerenti dal punto di vista tematico e omogenee per formato e tecnica pittorica. E, nell’universo sterminato delle immagini possibili, in quel duplicato del mondo che già Susan Sontag intuiva e paventava, Nahmad predilige assolutamente i ritratti, colti spesso a distanza piuttosto ravvicinata o, al massimo, raramente, a mezzo busto. I suoi sono dunque volti e famosissimi, i più celebri fra i celebri, inquadrati in un’immagine che a sua volta è scelta fra le più celebri di quelle disponibili per quel personaggio. Le sue immagini hanno dunque fatto storia e sono storia di per se stesse e contemporaneamente per il potere iconico del personaggi o che rappresentano.
Da questo punto di vista il lavoro di Barbara Nahmad si inquadra indubbiamente nel grande, epocale filone sdoganato dalla Pop Art e in particolare da Andy Warhol che, forse primo in assoluto, ha usato sistematicamente l’arte come metalinguaggio e, grazie ad essa, ha sottratto innumerevoli volte l’immagine trash, fatta per essere consumata, al suo destino che si usava definire “basso”, contenuto nei circuiti e nelle modalità della comunicazione di massa, e l’ha riproposta su un piano diverso, nobile e, se non eterno, almeno teoricamente fuori dal tempo.
Ma perché lì operazione Pop possa attuarsi l’immagine deve esistere già, anzi deve già essersi conquistata il proprio consenso e la propria diffusione nel mondo. Per definizione questo tipo di pittura non inventa il proprio soggetto ma lo trae bell’ e pronto, o meglio ready made, dai circuiti della comunicazione. E così fa appunto Barbara Nahmad, senza peraltro adottare la radicalità antipittorica di Warhol ma invece, come già Mario Schifano negli anni Sessanta (penso ai suoi dipinti dedicati alla Coca-Cola e simili), recuperando la pittura e re-investendola delle sue potenzialità linguistiche, cioè di un gusto tattile, cromatico, compositivo, di un piacere della pennellata, dell’ombreggiatura e del contrasto che non è improprio chiamare “stile”. Può darsi che in questa scelta, in questo modo di fare che rifiuta di sbarazzarsi della soggettività e dell’ esperienza della mano, ci sia qualcosa di tipicamente italiano, come il paragone con Schifano potrebbe suggerire; indubbiamente Nahmad non rinnega le sue origini e il suo radicamento in quella Milano dove, già alla fine degli anni Ottanta, il lavoro sulla pittura e con la pittura è stato assai alleggerito, spesso reso ironico e associato giocosamente e gioiosamente ad altri media, ma non è mai stato ricusato del tutto, nemmeno dalla generazione più schiettamente concettuale emersa insieme a Corrado Levi all’ inizio degli anni Novanta (Mario Airò, Marco Cingolani, Marco Mazzucconi, Alfredo Pirri, Massimo Kaufmann e altri).
Barbara Nahmad appartiene culturalmente a questo contesto, quello della manipolazione ironica, non aggressiva, e alle volte addirittura virtuosistica dell’immagine ma, a differenza di quello di altri suoi colleghi, il suo lavoro non perde di vista il passato, anzi insiste per riflettervi, per lavorare sulle tracce dell’esistente, sulle sopravvivenze, potremmo dire, di una memoria collettiva che ha sempre bisogno di creare e di continuare a rendere omaggio agli altari dei propri santi, miti ed eroi, e che di questa ritualità non è mai stanca. Per questo nel suo lavoro si nasconde, talvolta quasi impercettibile, un’aura vagamente malinconica, una sensibilità speciale per ciò che è perduto e che sopravvive solo nell’ icona, nel simulacro.
Le sue serie À rebours (2008), Canto General (2009), Yesterday Now (2005) e All’ultimo respiro (2010) quest’ultima rappresenta solo baci, ma di quelli che “bucano lo schermo”, grande o piccolo che sia; sono l’una l’ ideale continuazione dell’ altra, composta ciascuna da dipinti concepiti come perle di una stessa collana e dedicati a quelle icone dello spettacolo o della politica, a personaggi e intellettuali e cantanti e scienziati che più “ci mancano” (e mancano all’ artista), pur senza che sappiamo nulla di loro. La “star” infatti, confermava Ugo Volli in un testo di alcuni anni fa, “è sempre vuota”; ha superficie ma non ha corpo; ha apparenza ma non sostanza; e con tutto questo non è detto che non avvertiamo malinconicamente la sua assenza, il suo non esserci più: sia essa l’immancabile Marilyn, icona della bellezza Pop, oppure John Lennon e Yoko Ono nudi nel celeberrimo bed-in di protesta contro la guerra in Vietnam, sia Albert Einstein che guarda nel vuoto con un distaccato, dolce e impercettibile sorriso, oppure, dato che siamo in Italia, persino l’avvocato Gianni Agnelli che, carismatico e vagamente accigliato, decide le sorti dell’ automobile e della economia.
Facce, immagini, che hanno una storia e che appartengono alla grande famiglia delle occasioni perdute e delle ideologie tramontate, la protesta degli anni sessanta e settanta, le dive del cinema e della televisione, i sempreverdi del rock e perfino le grandi scene di bacio appassionato, come quello, ovviamente, fra Clark Gable e Vivien Leight in Via col vento, ma anche fra Madonna e Britney Spears (bacio che si suppone “vero”, di fronte alle telecamere nel 2003) e, par condicio ?, fra Leonid Breznev e Erich Honecker nel 1979 in occasione del trentesimo anniversario della DDR; o ancora, per tornare a sognare, quello fra Marcello Mastroianni e Anita Ekberg nella Dolce vita. Baci che, almeno in parte, continuano a piacerci moltissimo ma che oggi, forse, non sappiamo più dare. Per questo ne abbiamo nostalgia.
Dopo tutto questo, colpiscono le novità dell’ultimo ciclo di lavori di Barbara Nahmad, emerso, come tutti gli altri ma forse più degli altri, dopo anni di preparazione. Certo, non sono state alterate alcune sue caratteristiche fondamentali e distintive, a cominciare dal suo modo di lavorare su immagini già esistenti, e anche, entro certi limiti, dalla scelta di una pittura che tende a spogliarsi sempre di più dei dettagli superflui, rispetto al cuore del tema che ogni immagine affronta, e che predilige un’armonia di toni calibrata tutta sui bruni, ocra e grigi, con pochissime concessioni, sempre meno, a quei piacevoli fondi smaltati che animavano molti dipinti precedenti.
Ma la novità principale è costituita dal soggetto individuato dall’artista per questo nuovo racconto: i bambini. E non bambini qualunque ma, nella grande maggioranza, bambini degli anni Cinquanta e Sessanta nati in Israele, la prima generazione veramente israeliana dopo la fondazione dello stato. A dire la verità, questi bambini non sono del tutto soli: diverse immagini inquadrano anche i loro genitori, quei rappresentanti eccellenti del “Haadam Hahadash”, in ebraico “l’uomo nuovo”, quell’ individuo rinnovato dal sole e dalla Terra del Medio Oriente, finalmente riscattato e lontano dalle privazioni, le denigrazioni, l’infamante abbrutimento che aveva accompagnato per secoli e secoli il suo popolo nella diaspora.
Israele, la speranza, il paese nuovo finalmente venuto alla luce dopo tanto, incolmabile strazio, poco dopo la sua fondazione, ma anche prima, accoglieva i profughi accorsi con ogni mezzo dalla Europa e da tutte le coste mediterranee, divenute ostili e inospiti per gli ebrei nativi, a braccia aperte e mancando di tutto. La fondazione dello stato ebraico era stata osteggiata in ogni modo e salutata subito da una guerra sferrata da forze arabe congiunte, convinte di avere facilmente la meglio su quelle masse di disgraziati scampati dall’Olocausto e ancora privi di qualunque organizzazione. Invece no. Against all odds, quel piccolo miracolo politico di capacità, tenacia, determinazione e di volontà aveva resistito e chiamava le sue genti antiche all’ abbraccio di una vita nuova nella Terra sacra, la Terra di sempre.
Però, nonostante l’entusiasmo, la esistenza in Medio Oriente, lontano dalle città e dalle abitudini di vita europee, sotto un sole implacabile, fra colline aride, sterpaglie e un grande deserto, era durissima. Viverla richiedeva una trasformazione profonda, non meno profonda di quella a cui Israele sarebbe andato incontro nei decenni a venire: ed ecco dunque l’uomo nuovo, abbronzato e sorridente, capace di scrollarsi dalle spalle forti un passato di oppressione e tragedia, ma anche di abitudini borghesi, di cultura e mondanità, e di rimboccarsi le maniche per diventare contadino, operaio, costruttore, come quei suoi padri che avevano edificato i quartieri di Tel Aviv nello stile Bauhaus.
E non si tratta solo degli uomini: la Terra nuova è anche, altrettanto, una terra di donne, quelle donne cui è affidata la continuità del popolo ebraico e che nella organizzazione e nel lavoro dei kibbutz e delle città non sono state da meno dei loro compagni. Decise, convinte, esse hanno cercato e ottenuto, in generale, prima delle loro coetanee di altri paesi, una significativa base di uguaglianza, lavorando come i loro mariti, affrontando e condividendo le stesse speranze come anche le stesse difficoltà e le stesse durezze, le stesse fatiche impensabili nella loro esistenza precedente, coltivando la terra e formandosi nelle università, condividendo responsabilità e oneri, compreso, presto, quello della guerra e del servizio militare.
Tutto questo racconta Barbara Nahmad servendosi di fotografie dell’epoca, opportunamente “tradotte” in pittura attraverso una drastica eliminazione dei dettagli superflui e una messa a fuoco esclusiva del soggetto principale che emerge, così, quasi metafisico e certo malinconico in un mare di vuoto, da assenza di dettagli, appena appena segnata da qualche flebile linea per inquadrare sommariamente il contesto.
E racconta, come si diceva, soprattutto i bambini, squadre, branchi, nursery di bambini senza nome, nati spesso nei campi di accoglienza e nei kibbutz, figli della povertà, della fiducia e dell’entusiasmo dei loro genitori, che nonostante tutto accorrevano verso la nuova terra e si descrivevano in queste immagini che adesso Barbara Nahmad trasforma, non senza un’intensa partecipazione, in uno spaccato fedele, ma non illustrativo, di quella società; una società con i suoi desideri, speranze, simboli e utopie, il cui primo frutto sono proprio quei bambini raccontati senza alcun sentimentalismo ma con sguardo penetrante e obbiettivo. D’altra parte, già Mary Cassatt insegnava che non c’ è un altro modo di dipingere i bambini senza scadere nella più melensa e stucchevole delle affettazioni. Bisogna renderli come sono, con la loro goffaggine e la loro tenerezza, con le loro rigidità, le loro stupefazioni e tutto quell’universo interiore di sfumature psicologiche che i loro gesti rivelano, più, forse, di quelli divenuti adulti.
Dalle foto originali, Barbara Nahmad preleva solo ciò che le serve, limitando il contorno a poche linee di paesaggio o di contesto. Il fondo, ocra, quasi incolore, è intensamente pittorico, animato da sfumature da cui sembra trasparire la tessitura granulosa della tela. Niente di fotografico, insomma, anzi una dichiarata presa di distanza dalla stessa fonte fotografica. La pittura, infatti, consente di eliminare tutto il superfluo e di lasciare i protagonisti di ogni immagine quasi galleggiando isolati nel vuoto, inquadrati solo grazie a un disegno di poche linee che descrive una situazione nei suoi tratti più essenziali, senza affatto riprodurla. Ecco, per esempio, delinearsi la silhouette di un carro armato in disuso, adoperato come anomalo sedile da un grappolo di ragazzini seminudi tutti presi dall’ascolto dei racconti di una donna anziana, forse la nonna o una maestra. Essi indossano semplici cappellini bianchi per proteggersi dalla violenza micidiale del caldo e del sole mediterraneo, che rende abbacinante il riverbero e profondissime le ombre dipinte. In un altro lavoro, sono le sagome di alcuni soldati in movimento che si stagliano alle spalle di un abbraccio fra padre e figlio, quest’ultimo con le gambine esili che pendono fuori dai pantaloncini a sbuffo e semplici sandali a stringergli le caviglie ancora delicate.
Ma non c’ è solo la realtà della guerra, che pure esiste, dietro a queste immagini, c’è invece soprattutto la vita quotidiana di un paese dagli sguardi giovanissimi, spalancati sul futuro: non è forse quello che contempla la giovane coppia dipinta di spalle e quasi sperduta nell’ immensità, di fronte a sterminate distese di vuoto, verdi colline o dune del deserto, ma spazio comunque, spazio reale e metaforico tutto da vivere, da coltivare, da abitare?
È la stessa, trasparente fiducia che si legge nel volto sorridente, questo sì colto proprio di fronte, in un primo piano, di un uomo sui trent’anni, le maniche rimboccate, il sorriso semplice, addirittura ingenuo, gli occhi infossati in un cono d’ombra che guardano diritto davanti a sé e alle sue spalle il profilo appena accennato di un mulo aggiogato al carro.
È da lì che passa il rinnovamento, del corpo e dello spirito. Per carità, non è tutto: i ragazzini e le ragazzine che poco tempo dopo già affiancano numerosi questi pionieri, naturalmente vanno a scuola, dove infatti diversi dipinti li ritraggono, seduti a banchi troppo alti per loro, seri ed attenti forse a una spiegazione difficile, vestiti tutti uguali in classe come anche nelle palestre della ginnastica e nelle colonie estive, vere e proprie città per bambini che devono crescere nei principi della solidarietà e di una condivisione che all’ epoca sa molto di socialismo reale, una pratica di vita che impronta l’organizzazione dei kibbutz, dove tutta la ricchezza è gestita in comune, tutti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri e dove i bambini crescono tutti insieme, in apposite case – camerate dedicate esclusivamente a loro. Ecco che un’immagine li mostra infatti molto piccoli, gattonando su una coperta, nudi o coperti di una semplicissima e spartana canotta senza maniche. Un’altra invece coglie una ragazzina nel bagno comune, sola di fronte a uno scomodo lavabo con un unico rubinetto, intenta a lavarsi diligentemente il viso con legato in vita un rustico grembiulone che le lascia nude le gambe e il sederino rotondo.
Le immagini di Barbara Nahmad sono immensamente silenziose ma dicono moltissimo. Raccontano di una società dove tutti, anche i bambini piccoli, si assumono la responsabilità di sé stessi, dove il corpo e il benessere fisico occupano un posto importante; raccontano di una società collettivista dove la solitudine non sembra esistere, una società spartana dove c’è poco ma quel poco sostanzialmente deve bastare per tutti.
Un’oculatissima scelta delle immagini di riferimento permette all’artista di tracciare un ritratto fedele di questo mondo adolescente, la cui iconografia, il cui stile e il cui immaginario non è affatto diverso da quello che contemporaneamente si affermava, per esempio, in America, ma che differisce da quest’ultima per alcuni particolari diversi e caratteristici, per la mancanza di individualismo, per la sobrietà, per una specie di fiduciosa, incrollabile ingenuità, che si legge anche nei volti degli emigranti arrivati di fresco e ancora appollaiati sui loro bauli (in questo significativamente diversi dai loro predecessori miserabili e spossessati che arrivavano negli anni Dieci al porto di New York) e si legge in quella sfilata di fratellini tutti in fila e tutti in posa, ben sette in una famiglia sola, come accadeva nell’ Italia d’inizio secolo ma non degli anni Cinquanta. Se si giocasse, con queste immagini, al gioco delle differenze, sarebbero questi probabilmente i primi aspetti ad emergere, oltre ad alcuni temi, invece, specifici della società ebraica che l’artista non manca di raccontare: la Yeshivà dove studiano i ragazzini ortodossi, tutti maschi e quasi corrucciati sotto lo sguardo del maestro, la danza fra uomini, la musica klezmer ballata al ritmo battente di mani concordi e ispirate.
È tutto questo l’eden, il mitico giardino che presta il proprio nome (ma un nome con la lettera minuscola, appropriata a una dimensione che in questa pittura è laica e terrestre) a questa serie di opere, quel giardino che l’umanità aveva perduto all’inizio del suo biblico cammino e che da quel momento sempre aveva ispirato una perpetua e incrollabile speranza di ritrovamento.
La pittura forse non racconta la storia, e meno ancora la teologia. Ma essa può esprimere, o raccogliere in questo caso, le qualità salienti di un’immagine e sospenderla nel tempo, decantarla fino a distillarne tutto il senso – e l’atmosfera. Così, è questo eden desiderato, questa terra promessa e tanto a lungo, tanto brutalmente negata che respira nelle trasparenze di queste immagini, peraltro niente affatto edeniche, anzi profondamente obbiettive e quasi carezzevoli nella loro partecipazione, alleggerita dal rispetto e dalla distanza. Quell’ eden naturalmente perduto ma verso cui certo volerà l’ areoplanino giocattolo che un volitivo ed ottimista ragazzino dipinto tiene in mano, proprio accanto all’ asta della bandiera. Un areoplanino senza nessun colore ancora, ma pronto ad addentrarsi nel futuro, in quel futuro che lambisce il passato e dove l’eden sempre si troverà, davanti agli occhi di tutti i bambini di tutta la nuova Terra.
I GIORNI DELL'INNOCENZA
Amb. Avi Pazner
Quando il mio sguardo incontra le opere di Barbara Nahmad mi sento d’improvviso trasportato indietro, come in una macchina del tempo. Mi ritrovo alla fine degli anni ’40 e ’50 quando tutti i nostri sogni diventarono possibili e ci ritrovammo a vivere quella che era la stupenda avventura dell’indipendenza e della costruzione di una nazione.
Con la memoria vado a ritroso, mi rivedo quando arrivai in Israele con la mia famiglia, nel luglio del 1953. Lasciavamo la Svizzera, una terra che offre molto, per andare a vivere in un luogo in cui non c’era quasi nulla, un paese per lo più deserto in un periodo di grandi ristrettezze. Il cibo era razionato e la nostra famiglia, composta da sei membri, divideva con un’altra famiglia un piccolo appartamento di tre stanze. Non vi era granchè da mangiare, non avevamo un frigorifero o un forno e nemmeno un ventilatore, avevamo una radio, questo sì, che ascoltavamo tutto il giorno. Eravamo paghi di vivere in mezzo ad altri ebrei, di costruire un nuovo stato e di sentirci a casa, anche se non parlavamo ancora la lingua.
Quelli erano i giorni dell’innocenza, del sacrificio, del coraggio, dell’abnegazione e della mobilitazione per una giusta causa. Stavamo vivendo un momento storico, era il periodo in cui dopo la terribile tragedia dell’Olocausto, il popolo di Israele tornava alla sua terra originaria, dopo duemila anni. Nonostante fossimo poco armati, abbiamo vinto la guerra contro i sette eserciti che hanno invaso il nostro paese. Abbiamo pagato un prezzo altissimo, e’ vero, ma eravamo finalmente liberi nella nostra patria.
E’ stato anche un periodo di grande modestia, in cui seguivamo la disciplina che ci eravamo dati ma al tempo stesso ci aiutavamo a vicenda, condividendo le poche risorse a disposizione.
Nonostante fossimo soffocati da un clima di austerita’, colpiti da attacchi terroristici, senza infrastrutture nè industria e a volte senza cibo, eravamo comunque felici. A confortarci era una sorta di contentezza interiore, che è immateriale e spirituale, derivata dalla certezza che contro ogni pronostico ce l’avevamo fatta.
Questa e’ l’essenza che Barbara e’ riuscita a catturare ispirandosi alle fotografie di quel periodo, pieno di speranza e candore. Per un attimo, chi osserva, potrebbe pensare a una mostra di fotografia talmente questa pittura ne è intrisa, ma poi ci si rende conto subito che si sta guardando qualcosa di molto piu’ potente di una foto, perche’ in queste tele l’artista trasfonde totalmente il suo sentimento, identificandosi col tema trattato. Barbara e’ troppo giovane per aver vissuto personalmente quel momento storico ma è come se sapesse coglierne il suo significato profondo, riuscendo così a trasmettere ancora oggi quelle sensazioni lontane, emozionandoci.
Le fotografie sono importanti, sono la fondamentale testimonianza della storia, ma le opere di Nahmad fanno di più, riportano alla vita quei giorni, con un tocco di nostalgia e, ai miei occhi, un filo di malinconia. Guardando i suoi lavori proviamo un certo rimpianto per quegli anni in cui la vita sembrava piu’ semplice di quella di oggigiorno, nel mondo contemporaneo.
Barbara non ha solamente una profonda conoscenza di quel periodo e di ciò che rappresenta, ma in qualche modo lo ha fatto suo attraverso la sua arte, condividendone i sentimenti con coloro che quel periodo l’anno vissuto di persona. Ma l’aspetto ancora piu’ importante e’ che Barbara riesce a guidare in questo percorso di arricchimento coloro che non sanno come fosse la vita in Israele 60 anni fa.